NAVIGANDO
VERSO L'ESAME DI STATO
di Marino Martignon
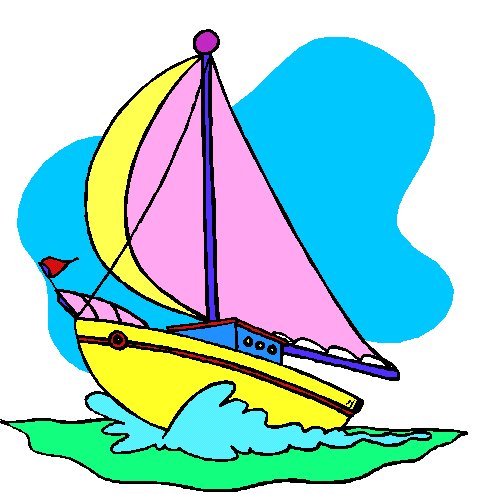
NAVIGANDO
VERSO L'ESAME DI STATO
di Marino Martignon
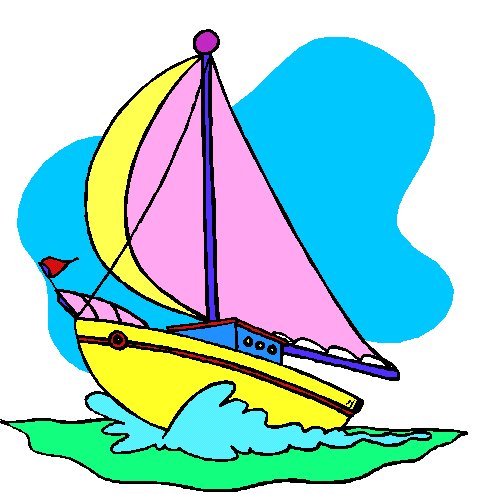
PREMESSA
Ho deciso di creare queste pagine per fornire un supporto ai colleghi e agli studenti che dovranno affrontare l'esame di Stato.
Ho pensato di dividere i contenuti in due parti distinte: una parte dedicata alla normativa di riferimento per gli esami di Stato, e una parte dedicata alla preparazione degli studenti per affrontare l'esame di Stato.
Come aiutare gli studenti ad affrontare l'esame (per insegnanti)
Sulla correzione della prima prova (importanti riflessioni prodotte dall'INVALSI)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ESAME DI STATO
Ultime indicazioni normative relative alle prove scritte e al colloquio
Ultime indicazioni normative relative al documento del 15 maggio
Nuovo esame di Stato: principali riferimenti normativi
I principali riferimenti normativi per l’esame di Stato sono i seguenti:
IL PUNTEGGIO
Il meccanismo per la elaborazione del voto finale prevede di partire dal punteggio di ammissione. Questo sarà dato dalla somma dei punti di credito scolastico e credito formativo (il punteggio massimo di ammissione è di 25 punti).
Al punteggio di ammissione si dovrà sommare il punteggio ottenuto nelle tre prove scritte (15 punti massimo per ogni prova, 10 punti indica una valutazione sufficiente), e il punteggio ottenuto al colloquio (30 punti massimo, 20 punti per una valutazione sufficiente). Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100.
Nel caso in cui il punteggio di ammissione non sia inferiore a 15 e la somma dei punteggi delle prove scritte e del colloquio arrivi a 70, la commissione può assegnare al candidato un bonus, massimo, di 5 punti.
Per quanti arrivino al punteggio di 100 senza fruire dell’integrazione del bonus è possibile l’attribuzione, da parte della commissione, della lode.
CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
La normativa di riferimento per il credito scolastico è il DM 42 del 2007.
Secondo quanto indicato nel decreto, per il credito scolastico si fa riferimento alla seguente tabella:
CREDITO
SCOLASTICO
Candidati interni
|
Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
||
|
|
I anno |
II anno |
III anno |
|
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
|
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
|
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
|
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
6-8 |
7-9 |
Nel dicembre del 2009 il DM 99 ha modificato la tabella per il credito scolastico a partire dall'anno scolastico 2009/10 per le classi terze (nella tabella è il primo anno) e a seguire negli anni successivi. La nuova tabella prevede per i candidati interni la seguente suddivisione del credito:
CREDITO
SCOLASTICO
Candidati interni
|
Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
||
|
|
I anno |
II anno |
III anno |
|
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
|
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
|
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
|
8 < M ≤ 9 |
6-7 |
6-7 |
7-8 |
|
9 < M ≤ 10 |
7-8 |
7-8 |
8-9 |
Per il credito formativo il riferimento normativo è l’articolo 12 del DPR 323, in questo articolo è indicato: (Crediti formativi) 1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto. Ulteriore importante normativa di riferimento per l’assegnazione del credito formativo è il DM 452 del 1998 e il DM n. 49 del 2000. L’Art. 1 del DM 49 recita: “Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.”
PROVE SCRITTE
Con riferimento alle tre prove scritte, così recitano il DPR 323 del 1998 e la Legge N. 1 del 2007:
DPR 323 del 1998
Art. 4 - (Contenuto ed esito dell'esame).
2. (L. 425, art.3, comma 1, e Regolamento) La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione decreto di cui all’articolo 5, comma 1.
3. (L. 425, art.3, comma 1, e Regolamento) La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l’ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.
4. (L. 425, art.3, comma 1, e Regolamento) La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell’ultimo anno.
Legge n. 1 del 2007
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame).
1. L'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato
all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno
del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di
ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità
critiche del candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova
scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua
nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere
anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti
il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli
istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto
della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e
possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova é
espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle
istituzioni scolastiche ed é strettamente correlata al piano dell'offerta
formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa é a carattere pluridisciplinare,
verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella
soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di
progetti; tale ultima prova é strutturata in modo da consentire, di norma, anche
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. […]
COLLOQUIO
Con riferimento al colloquio è indicato nel DPR 323 del 1998.
Art. 4 - (Contenuto ed esito dell'esame).
5. (L. 425, art.3, comma 3, e Regolamento) Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.
Art. 5 - (Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame)
7. (Regolamento) Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell’art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
I riferimenti a questo testo si trovano nel DPR 323 del 1998, in particolare così è indicato nell’articolo 5.
Art. 5 - (Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame)
2. (L. 425, art.3, comma 2, e Regolamento) Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi,, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.
Ultime indicazioni normative relative alle prove scritte e al colloquio
PRIMA PROVA
Il riferimento per la prima prova scritta è il DM 41 del 2003. Nel decreto ministeriale è indicatoArt. 1
Prima prova scritta
· La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività.
· Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca:
a. analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
b. sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;
c. sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
d. trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.
· Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
a. correttezza e proprietà nell'uso della lingua;
b. possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
c. attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.
· Nello svolgimento della prova di cui al comma 2 lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.
SECONDA PROVA
Il riferimento per la seconda prova scritta è sempre il DM 41 del 2003. Nel decreto ministeriale è indicato:
Art. 2
Seconda prova scritta
· La seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.
TERZA PROVA
Il riferimento per la terza prova scritta è il DM 429 del 2000. Nel decreto ministeriale è indicato:
Art. 1.
Finalità
1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.
Art. 2.
Tipologie e caratteristiche formali generali della prova
1. La prova, predisposta dalle commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:
a) trattazione sintetica di argomenti significativi anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole).
Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande;
b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a);
c) quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte.
Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso;
d) problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno;
e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica;
f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.
2. Nei licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
3. Negli istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.
Art. 3.
Scelta delle tipologie e articolazione della prova
1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:
a) non più di cinque argomenti per la trattazione sintetica;
b) da dieci a quindici quesiti a risposta singola;
c) da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla;
d) non più di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
e) non più di due casi pratici e professionali;
f) un progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
4. Le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.
5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.
Art. 4.
Accertamento della conoscenza della lingua straniera
1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalità:
a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato;
b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.
2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe.
COLLOQUIO
Il riferimento per il colloquio è l’OM n. 40 del 2009. Nell’ordinanza ministeriale è indicato:
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007,n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti posso no essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Ẻ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l’obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell’attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla
lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.
7. Nei predetti corsi, di cui al comma 6, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, lo studente sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le discipline linguistiche studiate dai singoli candidati e rappresentate in commissione.
8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.
9. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.
Ultime indicazioni normative relative al documento del 15 maggio
Il riferimento per il documento del consiglio di classe è l’OM n. 40 del 2009. Nell’ordinanza è indicato:
Art. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007,n. 235.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
INDICAZIONI PER PREPARARSI ALL'ESAME
(per studenti)
Sembrava non dovesse mai arrivare ma all'improvviso eccolo qua, inaspettato, prossimo, incombente è il TUO esame di Stato e non sai proprio cosa fare.
Le parole che seguono hanno lo scopo di aiutarti nell'affrontare con serenità e il massimo profitto il tuo prossimo esame.
Per iniziare ricorda tre cose importanti:
Non lasciarti prendere dal panico, è la peggior cosa
Inizia da subito la messa a punto del tuo esame, non aspettare le ultime due settimane
Informati bene sui meccanismi dell'esame, solo se comprendi bene come funziona potrai ottenere i migliori risultati
Non perdiamo altro tempo e seguimi con attenzione, ti presenterò il tuo prossimo esame.
COM'É STRUTTURATO L'ESAME DI STATO
L'esame che ti trovi ad affrontare è stato introdotto dall'anno scolastico 1998/99, nel corso degli anni vi sono state delle piccole modifiche che non hanno cambiato nella sostanza l'impianto della prova.
Tra le cose che più sono mutata negli anni vi sono le modalità di ammissione. Per il tuo prossimo esame i criteri di ammissione sono indicati nel DPR 22 giugno 2009, n. 122, per poter essere ammesso all'esame devi avere la sufficienza in tutte le materie, vedi art. 6, (anche la condotta viene considerata per l'ammissione, una valutazione insufficiente in condotta significa la non ammissione). Vista questa premessa, probabilmente stai già pensando di abbandonare, non farlo. Considera che questo è il primo anno che viene recepita questa norma così rigida, probabilmente il consiglio di classe terrà conto della cosa e un eventuale cinque potrebbe, dico potrebbe, diventare sei, ciò naturalmente se hai dimostrato di dare il massimo per recuperarlo (ti ricordo che gli insegnanti della materia propongono il voto ma è il consiglio di classe che lo assegna). Scommetto che sei già arrabbiato, della serie ... "Ma proprio quest'anno dovevano iniziare con questa storia della sufficienza in tutte le materie, proprio quest'anno che tocca a me. Sono sempre il solito sf.... (sfortunato!)". Allora ti posso dire, per rincuorarti, che questa storia della sufficienza in tutte le materie alla fine ti potrebbe tornare utile per la media di ammissione. I tuoi compagni, lo scorso anno, sono stati ammessi anche con delle insufficienze e la loro media di ammissione ne ha risentito, per te non sarà così visto che devi avere almeno sei nelle diverse materie.
IL PUNTEGGIO D'ESAME
Come probabilmente già saprai il punteggio minimo che devi raggiungere per superare l'esame è di 60 punti. Il punteggio massimo è di 100 punti (se vi sono particolare condizioni ti può essere assegnata anche la lode, lo vedremo dopo).
Il punteggio d'esame è costituito dalla somma di cinque elementi (più un bonus e una lode eventuali):
Punteggio di ammissione
Prima prova
Seconda prova
Terza prova
Colloquio
Bonus e lode (eventuali)
1. Punteggio di ammissione
Il punteggio di ammissione è dato dalla somma del credito scolastico e del credito formativo.
Il credito scolastico è legato alla media dei voti degli ultimi tre anni. L'ultimo riferimento normativo per il credito scolastico è il DM 42 del 2007. Secondo quanto indicato nel decreto, per il credito scolastico si fa riferimento alla seguente tabella:
CREDITO
SCOLASTICO
Candidati interni
|
Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
||
|
|
I anno |
II anno |
III anno |
|
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
|
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
|
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
|
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
6-8 |
7-9 |
Per il credito formativo la questione è più complicata. La normativa di riferimento, a mio parere, non è per nulla chiara (puoi trovare i riferimenti normativi a questo proposito all'inizio della pagina). Il credito formativo viene assegnato quando uno studenti possiede delle documentate esperienze formative, svolte al di fuori della scuola. Le esperienze possono essere relative all'attività professionale di riferimento per quel corso di studi (ad esempio per uno studente che frequenta un istituto professionale, lo svolgere già una qualche attività lavorativa legata all'indirizzo di studi) o ad attività sportive, di volontariato, ecc.. Come scritto sopra, non è per nulla chiara la normativa di riferimento, si parla di due punti massimo per studenti lavoratori che si presentino come privatisti, per gli studenti interni non si parla di punti in più. Le diverse scuole si comportano, di conseguenza, secondo criteri diversi, alcune assegnano dei punti in più, fino ad un massimo di due, per il credito formativo, altre considerano il credito nell'assegnare il punteggio più alto nella fascia dei crediti scolastici (ad esempio se hai una media di 7,3 e sei in quinta potrebbero darti 7 punti di credito scolastico perché possiedi un credito formativo. In ogni caso ti conviene verificare come la tua scuola considera il credito formativo.
Il punteggio massimo di ammissione è di 25 punti.
2. Prima prova
La prima prova viene valutata con un punteggio massimo di 15 punti. Una prova sufficiente viene valutata 10 punti.
3. Seconda prova
La seconda prova viene valutata con un punteggio massimo di 15 punti. Una prova sufficiente viene valutata 10 punti.
4. Terza prova
La terza prova viene valutata con un punteggio massimo di 15 punti. Una prova sufficiente viene valutata 10 punti.
5. Colloquio
Il colloquio viene valutato con un punteggio massimo di 30 punti. Un colloquio sufficiente viene valutato 20 punti.
6. Bonus e lode (eventuali)
Nel caso in cui il punteggio di ammissione non sia inferiore a 15 e la somma dei punteggi delle prove scritte e del colloquio arrivi a 70, la commissione può assegnare al candidato un bonus, massimo, di 5 punti.
Per quanti arrivino al punteggio di 100 senza fruire dell’integrazione del bonus è possibile l’attribuzione, da parte della commissione, della lode.
La prova di Italiano ha subito, con il nuovo esame, un radicale mutamento. Prima del nuovo esame al candidato venivano proposte più tracce, alcune legate all'indirizzo di studi seguito, senza particolari indicazioni sulle modalità di svolgimento e sulla tipologia dei testi da costruire, con il nuovo esame molto è cambiato. Molto non tutto, l'ultima tipologia di testo proposta, la Tipologia D, è esattamente uguale alle tipologie di tracce proposte fino al 1998. Il punto è che ora hai una sola traccia di quel tipo perciò se dovessero proporti una traccia Tipologia D difficile da svolgere saresti, come si dice, "fregato". Meglio quindi non partire con l'idea non mi interessano la altre tipologie di prove tanto io farò la tipologia D, questo ragionamento è sbagliato. E poi le altre tipologie non sono così difficili come credi, si tratta solo di conoscerle un poco meglio, questo cercherò di fare nelle prossime righe, fartele conoscere un poco meglio, sono sicuro che il/la tuo/tua prof. te ne ha già parlato molto.
Quante sono le possibili tracce che puoi svolgere?
Allora la prima prova è così strutturata:
Tipologia A (una sola possibile traccia da svolgere)
Tipologia B (quattro possibili tracce da svolgere nella modalità articolo di giornale o saggio breve, legate a quattro ambiti: artistico-letterario; socio-economico; storico-politico; tecnico-scientifico)
Tipologia C (una sola possibile traccia da svolgere)
Tipologia D (una sola possibile traccia da svolgere)
Quindi complessivamente hai sette possibili tracce da svolgere (e per le quattro tracce della tipologia B hai due possibili forme: saggio breve e articolo di giornale), per questo è un peccato fissarsi sulla tipologia D, senza considerare le altre proposte.
Bene allora possiamo passare ad analizzare le diverse tipologie della prima prova.
Tipologia A
Analisi di un testo poetico/narrativo
In questo tipo di prova devi dimostrare la tua abilità nell’analisi di un testo poetico/narrativo e le tue conoscenze-competenze di storia della Letteratura
Se si tratta di un testo poetico, con riferimento al brano e all’autore ti verranno poste delle domande divise secondo lo schema:
Comprensione del testo (fare la parafrasi)
Analisi del testo
Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Se si tratta di un testo narrativo, con riferimento al brano e all’autore ti verranno poste delle domande divise secondo lo schema:
Per questa prova dovrai dimostrare:
Tipologia B
Elaborazione di un testo nella forma del saggio breve o dell’articolo di giornale
Per questa prova devi mostrare la tua abilità nel costruire un testo (nella forma del saggio breve o dell’articolo di giornale a tua scelta) utilizzando sia il dossier di documentazione (fornito quale parte integrante della prova), sia le tue conoscenze personali.
Gli ambiti
La tipologia B si distingue in quattro ambiti:
ARTISTICO-LETTERARIO
SOCIO-ECONOMICO
STORICO-POLITICO
TECNICO-SCIENTIFICO
Scegli l’ambito dopo aver letto i diversi argomenti proposti nei vari ambiti e avendo ponderato con attenzione l’ambito nel quale ritieni di saperti muovere meglio, per percorso di studi seguito (si immagina che uno studente frequentante l’istituto tecnico si trovi più a suo agio affrontando l’ambito Tecnico-scientifico rispetto a quello Artistico-letterario)e per i tuoi personali interessi.
L’argomento
Per ogni ambito ti viene proposto un particolare argomento guida. Ad esempio per l’esame del 2006 nell’Ambito artistico-letterario l’argomento proposto era: “Il distacco nell’esperienza ricorrente dell’esistenza umana: senso di perdita e di straniamento, fruttuoso percorso di crescita personale.”; nello stesso anno per l’Ambito tecnico-scientifico l’argomento proposto era: “Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul mondo che ci circonda, su noi stessi e sul senso della vita ?”. L’argomento ti consente di comprendere di cosa si sta parlando, può esserti utile per trovare un titolo al tuo pezzo.
I documenti
Per ogni ambito vengono quindi forniti dei documenti (in un numero variabili da 4 a 8) che in qualche modo fanno riferimento all’argomento proposto. I documenti forniti devono essere visti come una risorsa, non come un ostacolo. Non devi nemmeno essere messo in soggezione dai contenuti dei documenti, se possiedi delle tue informazioni relative all’argomento, che ti possono essere utili per costruire il pezzo, usale pure tranquillamente (ciò è indicato anche nelle consegne). L’uso dei documenti cambia a seconda che tu voglia scrivere un saggio breve o un articolo di giornale. Per il saggio breve devi riuscire a far uso di più documenti, analizzando i diversi contenuti e cercando, quindi, di utilizzarli secondo un piano ordinato, organico, coerente. Per l’articolo di giornale l’utilizzo dei documenti può essere anche limitato, individua nei documenti (nelle informazioni da questi fornite) uno o più elementi sui quali costruire il tuo pezzo.
Ricorda, infine, che devi leggere con attenzione tutti i documenti per individuarne i contenuti informativi (ti consiglio di redigere un breve riassunto dei vari documenti, avrai così la possibilità di osservarne con più facilità i contenuti informativi).
Le consegne da rispettare
Rispetto alle altre tipologie di prove, per la Tipologia B vengono date delle consegne piuttosto precise che devi assolutamente rispettare in merito a:
Titolo del pezzo (devi trovare ed indicare chiaramente, distinguendolo dal corpo del testo, il titolo del tuo saggio/articolo). Il titolo deve chiaramente essere coerente con i contenuti del testo elaborato, per questo motivo è preferibile indicare il titolo dopo aver costruito il testo. Il titolo non deve essere assolutamente trascurato, è con il titolo che ti presenti al lettore, il titolo ha la capacità di orientare rispetto ai contenuti e alla impostazione data al testo. Nel caso dell’articolo di giornale puoi utilizzare un titolo ad effetto per stimolare la curiosità del lettore e attirarne l’attenzione. Per comprendere quanta importanza può avere il titolo, proviamo ad immaginare di voler scrivere un pezzo sull’argomento “Pena di morte”, dopo aver consultato documenti costruisco il mio brano e quindi cerco un titolo adeguato, in base al titolo il lettore si aspetta dei contenuti diversi, ad esempio:
- Pena di morte (titolo amorfo che non mi dice nulla in merito ai contenuti, ripete semplicemente l’argomento, da evitare)
- La pena di morte nel terzo millennio (mi aspetto di trovare delle indicazioni relative alla attuale diffusione della condanna a morte nel
nostro tempo)
- La pena di morte. Nel terzo millennio ? (rispetto al precedente ho modificato solo la punteggiatura, eppure cambia l’attesa del lettore,
qui mi aspetto di trovare una presa di posizione chiara rispetto all’esistenza della condanna a morte anche nel terzo millennio)
- Nessuno tocchi Caino ! (in questo caso è evidente la posizione di contrarietà alla pena di morte, questo mi aspetto di trovar nel testo,
dato il titolo)
Destinazione editoriale (devi immaginare ed indicare, distinguendola dal corpo del testo, la destinazione editoriale, ossia dove pensi di far pubblicare il tuo saggio/articolo). Purtroppo anche la destinazione editoriale viene trascurata, spesso viene indicato senza pensarci il nome di una rivista qualsiasi, è un grave errore. Dare delle indicazioni sulla destinazione editoriale non è fine a se stesso, a seconda della destinazione editoriale cambia: il lessico; la struttura morfosintattica; lo stile. Uuna cosa è indicare quale destinazione editoriale la rivista “Le Scienze”, altra cosa “Focus junior”, i lettori delle riviste sono diversi. La seconda rivista si distingue dalla prima per il carattere maggiormente divulgativo e per essere destinata ad un pubblico di ragazzi, di conseguenza dovrà essere di più facile lettura, si accetta una minore rigorosità.
Lunghezza del testo (non più di quattro/cinque colonne di metà di foglio protocollo)
Uso dei documenti proposti (devi usare i documenti proposti, è un errore, purtroppo piuttosto diffuso, non tenere nella dovuta considerazione il dossier dei documenti allegati)
Ti consiglio, infine, di indicare se si tratta di saggio breve o articolo di giornale, per evitare possibili, spiacevoli, equivoci
Le caratteristiche del testo (saggio breve)
Funzione
Il saggio breve può avere scopo prevalentemente espositivo-informativo e quindi richiede una esposizione organica, lineare e chiara. Ma può avere anche carattere argomentativo, in questo caso deve essere chiara la tesi sostenuta dall’autore (posso riprendere la tesi nel titolo, abbiamo visto prima il titolo “Nessuno tocchi Caino”, in questo titolo è chiaramente espressa una tesi che mi aspetto di trovare nel testo) e devono essere usati con coerenza argomenti a sostegno della tesi.
Struttura
La struttura muta in base alla caratteristica del testo, è diverso un testo espositivo rispetto ad uno argomentativo, diciamo che in ogni caso è bene inserire un’introduzione ed una conclusione, tra introduzione e conclusione strutturare il testo in base alla tipologia, riportare dati, opinioni, per il testo espositivo, tesi e argomenti a sostegno della tesi per l’argomentativo. E’ possibile articolare il testo in paragrafi, dando un titolo ad ogni paragrafo. Si possono inserire note a fondo pagina. Quando si cita un documento del dossier è necessario indicare l’autore, se si riportano parti del documento dobbiamo mettere le virgolette e quindi riportare il testo che ci interessa, indicando l’autore. Per il saggio breve si deve evitare l’uso della prima persona, il testo deve essere impersonale.
Le caratteristiche del testo (articolo di giornale)
Funzione
Rispetto al saggio breve, l’articolo di giornale ha una notevole possibile varietà di funzioni. Possiamo avere articoli di cronaca, di opinione, interviste, recensioni, articoli specialistici. L’articolo di cronaca nasce dal voler raccontare un fatto, un evento accaduto, perciò se fai questa scelta devi inventarti un fatto per poi poterlo raccontare. Per la recensione devi fare riferimento ad una mostra, ad un evento culturale, o ad un libro per presentarlo al lettore. L’articolo specialistico prevede, poi, delle tue conoscenze approfondite su un determinato argomento di cui vuoi informare il lettore. L’articolo d’opinione (forse il più facile da scrivere per uno studente) ha funzione prevalentemente persuasiva, si tratta, quindi, di sviluppare un’idea, una tesi, in modo da persuadere il lettore, cercando magari di mantenere una apparente oggettività.
Struttura
Rispetto al saggio breve l’articolo di giornale si caratterizza per la necessaria presenza di una notizia che diventa il pretesto per scrivere l’articolo, ad esempio l’ultimo importante arrivo di immigrati clandestini a Lampedusa può essere utilizzato come notizia di partenza per costruire un articolo di fondo sul tema dell’immigrazione clandestina in Italia. Ecco perciò che quella che è l’introduzione nel saggio breve diventa l’attacco (lead o incipit) nel quale viene esposto un fatto (che ha lo scopo di incuriosire e stimolare il lettore nel continuare la lettura), si prosegue con l’analisi del problema, quindi si riportano le varie opinioni sul problema e infine il proprio punto di vista, si può concludere con un finale ad effetto. Anche per l’articolo di giornale quando si citano i documenti bisogna indicarne l’autore, e quando si riportano parti del testo è necessario metterle tra virgolette, specificando da dove sono tratte.
Tipologia C
Tema di argomento storico
In questo tipo di prova devi dimostrare la tua abilità nella costruzione di un testo di argomento storico. Il punto è che non ti viene offerto del materiale su cui lavorare, del materiale da cui trarre le informazioni, sei tu l’unica fonte da cui ricavare le informazioni che ti servono e questo potrebbe essere un problema. Potresti non aver affrontato nella sua specificità quel particolare argomento, e anche nel caso l’avessi studiato potresti comunque avere delle difficoltà nel ricordare in modo sufficientemente preciso l’argomento proposto. Chiaramente ciò dipende, innanzitutto, da come hai studiato storia nel corso dell’anno scolastico. Vediamo meglio di cosa si tratta analizzando brevemente i titoli che hanno dato negli ultimi tre anni scolastici:
2006/07
La fine del colonialismo moderno e l’avvento del neocolonialismo tra le cause del fenomeno dell’immigrazione nei Paesi europei. Illustra le conseguenze della colonizzazione nel cosiddetto Terzo Mondo, soffermandoti sulle ragioni degli imponenti flussi di immigrati nell’odierna Europa e sui nuovi scenari che si aprono nei rapporti tra i popoli.
2007/08
Cittadinanza femminile e condizione della donna nel divenire dell’Italia del Novecento.
Illustra i più significativi mutamenti intervenuti nella condizione femminile sotto i diversi profili (giuridico, economico, sociale, culturale) e spiegane le cause e le conseguenze.
Puoi anche riferirti, se lo ritieni, a figure femminili di particolare rilievo nella vita culturale e sociale del nostro Paese.
2008/09
Nel 2011 si celebreranno i 150 anni dell’unità d’Italia. La storia dello Stato nazionale italiano si caratterizza per la
successione di tre tipi di regime: liberale monarchico, fascista e democratico repubblicano.
Il candidato si soffermi sulle fasi di passaggio dal regime liberale monarchico a quello fascista e dal regime
fascista a quello democratico repubblicano. Evidenzi, inoltre, le caratteristiche fondamentali dei tre tipi di regime.
Partiamo dal primo titolo. Dopo aver introdotto l’argomento, ossia la fine del colonialismo e l’avvento del neocolonialismo, viene esplicitamente chiesto al candidato: “Illustra le conseguenze della colonizzazione del cosiddetto Terzo Mondo” e quindi “soffermandoti sulle ragioni degli imponenti flussi di immigrati nell’odierna Europa”. In sostanza ciò che ti viene chiesto è: 1. Conseguenze della colonizzazione nei territori di quello che viene chiamato Terzo Mondo
2. Conseguenze della fine della colonizzazione nei paesi del Terzo Mondo
3. Perché le persone scappano dai territori del Terzo Mondo
4. Quali conseguenze per i popoli europei nel dover gestire un così imponente flusso migratorio.
Come puoi osservare ti vengono chieste delle cose piuttosto precise alle quali non puoi rispondere in modo vago o secondo delle idee che tu ti sei fatto a proposito. Se non possiedi delle conoscenze specifiche su questi argomenti ti conviene nemmeno tentare di affrontarli.
Per il secondo titolo non cambia poi molto. In questo caso l’argomento è la condizione della donna nell’Italia del Novecento. Ti viene esplicitamente richiesto: “Illustra i più significativi mutamenti intervenuti nella condizione femminile sotto i diversi profili (giuridico, economico, sociale, culturale) e spiegane le cause e le conseguenze.” Di fronte a questa domanda non vi sono molte possibilità o conosci quali sono i più significativi mutamenti (comprese cause e conseguenze) nella condizione femminile della donna italiana nel Novecento o è meglio lasciar perdere.
Infine il terzo titolo, probabilmente quello più facile. In questo caso si tratta di focalizzare l’attenzione sui momenti di passaggio tra i tre tipi di regime che si sono succeduti in Italia nel corso di 150 anni di storia. Non è da sottovalutare l’ultima parte della domanda, quando si chiede di evidenziare “le caratteristiche fondamentali dei tre tipi di regime”. Forse quest’ultima parte è la più difficile, là dove si chiede di specificare degli elementi caratterizzanti le tre diverse strutture politico-istituzionali. In ogni caso anche per questa terza traccia è necessario possedere delle precise informazioni di carattere storico da riportare.
Non voglio presentarti come impossibile affrontare questa tipologia di prova, ti consiglio però di farlo solo se possiedi sufficienti informazioni sull’argomento proposto.
Ricorda di usare una forma impersonale nell’esposizione, tralascia l’esposizione di giudizi personali in merito ai diversi avvenimenti storici riportati.
Usa un lessico quanto più preciso e uno stile adeguato.
Tipologia D
Tema di ordine generale
Tra le quattro tipologie di temi proposti questa è quella che dovresti conoscere meglio. Si tratta, infatti, del classico tema, il tema che hai affrontato chissà quante volte nel tuo percorso scolastico. La tipologia conosciuta non deve, però, ingannarti. Ti consiglio di leggere con notevole attenzione la traccia che potrebbe essere più complessa di quello che sembra ad una prima lettura. Il rischio principale per questo tipo di prova è di andare fuori tema, ossia di non rispondere adeguatamente a quello che ti viene chiesto nella traccia. Anche in questo caso vediamo i titoli degli ultimi tre anni per comprendere come conveniva affrontarli.
2006/07
«L’industrializzazione ha distrutto il villaggio, e l’uomo, che viveva in comunità, è diventato folla solitaria nelle megalopoli. La televisione ha ricostruito il «villaggio globale», ma non c’è il dialogo corale al quale tutti partecipavano nel borgo attorno al castello o alla pieve. Ed è cosa molto diversa guardare i fatti del mondo passivamente, o partecipare ai fatti della comunità.»
G. TAMBURRANO, Il cittadino e il potere, in “In nome del Padre”, Bari, 1983
Discuti l’affermazione citata, precisando se, a tuo avviso, in essa possa ravvisarsi un senso di “nostalgia” per il passato o l’esigenza, diffusa nella società contemporanea, di intessere un dialogo meno formale con la comunità circostante.
2007/08
Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così idee e sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. Non è possibile definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della differenza delle modalità di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra gli uomini: quanto quella di ieri era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, impronte e attesa, tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e immediata.
Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali, gli aspetti che ritieni più significativi.
2008/09
Con legge n. 61 del 15 aprile 2005, il 9 novembre è stato dichiarato «Giorno della libertà», “quale ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo”.
A vent’anni dalla caduta del muro di Berlino, il candidato rifletta sul valore simbolico di quell’evento ed esprima la propria opinione sul significato di “libertà” e di “democrazia”.
Nel primo titolo si parte da un testo di Tamburrano per proporre l’argomento su cui riflettere. Si invita il candidato a discutere l’affermazione riportata, chiedendogli quindi se per lui in quell’affermazione domina la “nostalgia” o l’esigenza di un cambiamento.
Discutere l’affermazione riportata non è facile. In essa vi è una netta presa di posizione in merito al rapporto tra le persone, così com’era nel “villaggio” della società pre-industriale e com’è oggi nella “megalopoli”. In questo caso hai due possibilità o sostieni la tesi dell’autore portando anche tu degli argomenti a sostegno della tesi, o tenti di demolirla, proponendo una tua tesi, diversa da quella proposta, e gli argomenti a sostegno della tua tesi. Per quanto riguarda la “nostalgia” o il desiderio di cambiamento mi sembra chiaro che sia il desiderio di cambiamento a dominare.
Nel secondo titolo, più semplice, ti viene chiesto di riflettere in merito ai possibili cambiamenti che possono essere intervenuti nelle relazioni tra gli uomini in seguito al mutamento degli strumenti usati per comunicare. Quindi ti viene chiesto di confrontare la forma di comunicazione che usi tu oggi con le forme di comunicazione usate nel passato. Nell’ultima parte della traccia ti viene esplicitamente chiesto di riferirti a tue personali conoscenze ed esperienze a proposito. Date le premesse imposta un tema che sia quanto più possibile legato alle tue esperienze, e attenzione quando si dice “tue” non si intende solo le esperienze direttamente da te vissute, ma si comprendono anche le esperienze di amici o di parenti di cui sei venuto a conoscenza. Potresti far riferimento alle lettere che i tuoi genitori si inviavano quando erano fidanzati e confrontarle con i messaggi che scambi con la persona che ami e da lì partire con le tue riflessioni.
Infine il terzo titolo, che trovo piuttosto difficile. Molti studenti hanno inteso questa traccia come un titolo di argomento storico e si sono affannati nel ricostruire esattamente e a raccontare come è andata nel 1989, quando è caduto il muro di Berlino. In realtà questo tema di storico ha molto poco. La caduta del muro di Berlino ha un valore solo “simbolico”, un elemento da cui partire per sviluppare un testo che certo non dovrà essere focalizzato su quel particolare evento. Questa traccia non chiede al candidato di parlare della caduta del muro di Berlino, gli chiede, invece, di esporre le proprie idee in merito ai possibili significati dei concetti di libertà e di democrazia nel mondo contemporaneo. Per questo il tema è piuttosto difficile per uno studente di 18-19 anni, e per questo molti studenti sono andati fuori tema.
Non bisogna quindi lasciarsi ingannare dalla tipologia conosciuta, leggi con attenzione le tracce al fine di comprendere esattamente cosa ti viene richiesto, solo allora parti a costruire il tuo testo.
La cosa che maggiormente apprezzo nel leggere il tema di ordine generale è l’originalità nello sviluppo della traccia. Originalità da intendersi come capacità di andare oltre la superficie, oltre la banalità, che dimostri la tua abilità nello scavare in profondità.
Questo tipo di prova si sviluppa in prima persona ed è molto simile al testo di carattere argomentativo, in essa ti viene chiesto esplicitamente un parere, un’idea, una riflessione personale in merito all’argomento trattato.
La prima prova, comune a tutte le scuole, è sempre di Italiano. La seconda prova, invece, differisce da indirizzo ad indirizzo e cambia negli anni.
Nella scuola dove insegno sono due le materie che si alternano per la seconda prova: "Gnatologia" e "Scienza dei materiali dentali".
Si viene a conoscenza di quale materia è coinvolta come seconda prova per l'esame nel mese di gennaio.
Insegnando Italiano non sono in grado di fornire dettagliati consigli sul come affrontare la seconda prova. Vi posso, però, proporre la griglia di valutazione utilizzata dai colleghi, una sua attenta lettura può aiutarvi nell'affrontare correttamente la prova:
Seconda prova scritta
Griglia di valutazione
Valutazione in 15esimi
Candidato ________________________________________________ classe ___________________
INDICATORI |
PUNTEGGIO MASSIMO
|
PUNTEGGIO AI DIVERSI LIVELLI |
DESCRITTORI
|
|
Individuazione della strategia risolutiva |
3 punti |
0
1
2
3 |
- Non sa come affrontare il problema.
- La strategia individuata è insoddisfacente, non porta alla soluzione del problema.
- Riesce ad orientarsi, individua la corretta strategia.
- Mostra sicurezza nell’individuare ed applicare la strategia risolutiva del caso.
|
|
Conoscenza di regole e principi |
5 punti |
0
2
3,5
4
5 |
- Mostra di non conoscere nessuna regola o principio risolutivo del caso.
- Conosce solo alcune regole e principi utilizzabili.
- Dimostra una sufficiente conoscenza delle regole e dei principi.
- Dimostra una buona conoscenza delle regole e dei principi.
- Conosce tutte le regole e i principi necessari alla soluzione del caso. |
|
Capacità di applicare le regole al caso specifico |
3 punti |
0
1
2
3 |
- Non sa applicare al caso specifico le regole conosciute.
- Applica in modo non del tutto corretto le regole.
- Applica in modo sostanzialmente corretto le regole al caso specifico.
- Applica in modo ottimale le regole conosciute al caso proposto.
|
|
Correttezza della esecuzione |
4 punti |
0
1,5
2,5
3,5
4 |
- Commette numerosi e gravi errori nell’esecuzione della prova.
- Compie alcuni errori nell’esecuzione.
- Prova sostanzialmente corretta nell’esecuzione.
- Buona l’esecuzione della prova.
- Ottima l’esecuzione, non vi sono errori o sono irrilevanti. |
Voto complessivo attribuito alla prova: ________/15
Il riferimento per la terza prova è il DM 429 del 2000. Riporto parte del decreto in modo che tu possa sapere cosa ti aspetta.
Art. 1.
Finalità
1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.
Art. 2.
Tipologie e caratteristiche formali generali della prova
1. La prova, predisposta dalle commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:
a) trattazione sintetica di argomenti significativi anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole).
Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande;
b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a);
c) quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte.
Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso;
d) problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno;
e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica;
f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.
2. Nei licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
3. Negli istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.
Art. 3.
Scelta delle tipologie e articolazione della prova
1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:
a) non più di cinque argomenti per la trattazione sintetica;
b) da dieci a quindici quesiti a risposta singola;
c) da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla;
d) non più di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
e) non più di due casi pratici e professionali;
f) un progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
Le tipologie più diffuse per le terze prove sono le tipologie B (quesiti a risposta singola) e C (quesiti a risposta multipla) e le B-C assieme.
Massimo cinque sono le materie che potranno esserti date assieme nella terza prova (normalmente però si danno quattro materie). Il numero di domande varia a seconda la tipologia, per la tipologia B variano da 10 a 15, per la C da trenta a quaranta, per la B e C assieme minimo 8 domande a risposta singola e minimo 16 a riposta multipla.
Nel corso dell'anno scolastico ti verranno proposte delle simulazioni di terza prova, considera che la commissione non è costretta a darti prove simili, per tipologia a quelle che hai affrontato durante l'anno, tuttavia è molto probabile che se nelle simulazioni hai affrontato la tipologia B, nel momento dell'esame ti venga riproposta la tipologia B.
Quali materie verranno scelte per la terza prova è impossibile dirlo. Considera che la scelta viene fatta dalla commissione i giorni dell'esame. Di una cosa puoi però stare certo, per poterti dare quella materia nella terza prova ci deve essere un docente in grado di porre le domande e correggere le risposte. Se nella commissione non c'è l'insegnante di educazione fisica è impossibile che ti diano questa materia nella terza prova (attento alla materia insegnata dal presidente di commissione, ricorda che anche lui può elaborare le domande della terza prova e interrogarti durante il colloquio). Non escludere a priori materie come Italiano, tanto c'è nella prima prova. Con i miei studenti ho dovuto mettere Italiano nella terza prova, qualche anno fa.
INTRODUZIONE
Il colloquio è la prova che ha il maggior peso sul punteggio finale. Circa un terzo del punteggio si raccoglie, infatti, grazie al colloquio (ricordo che 30 è il punteggio massimo che può essere assegnato al colloquio, 30+5 se consideriamo anche l'eventuale bonus, 20 punti viene valutato un colloquio sufficiente). Certo il punteggio del colloquio non può fare miracoli, se nell'insieme (punteggio di ammissione e tre prove scritte) hai raccolto 40 punti non puoi sperare di arrivare a 100 (matematicamente impossibile), tuttavia un buon colloquio può fare veramente la differenza, può consentirti di uscire con una valutazione appena sufficiente o buona, buona o ottima, ecc.
COME SI SVOLGE IL COLLOQUIO D'ESAME
Il colloquio dura, in media, 45-50 minuti (ti sembrano un'eternità ora, ma quando sarai interrogato passeranno in un lampo). La modalità di svolgimento è la seguente:
1. Nell'OM 40 del 2009 è indicato: "il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto."
Quindi nel momento iniziale ti vengono concessi 10-15 minuti (in base alle tue necessità) per esporre l'argomento scelto. L'esposizione
dell'argomento può essere fatta anche con il supporto di strumenti multimediali. Puoi accompagnare la presentazione orale con un lavoro scritto,
quello che per comodità viene chiamato "tesina".
2. Finita l'esposizione dell'argomento, ti possono venir fatte delle domande sull'argomento a chiarimento o di approfondimento su quanto esposto.
3. Si passa quindi alle domande formulate dai diversi commissari (ti ricordo che tutti i commissari ti faranno delle domande, quindi devi essere
preparato su tutte le materie insegnate dai commissari presenti in commissione) inerenti il programma svolto nel corso dell'anno scolastico
4. A questo punto si passa alla presentazione delle prove scritte, per mostrarti gli errori e per verificare la tua capacità di autocorrezione.
5. Verrai invitato perciò ad uscire e, nei dieci minuti che passano prima della chiamata del candidato successivo, si decide il voto.
Quindi ricapitolando, esposizione dell'argomento e domande fatte dai commissari. Vediamo come prepararsi al meglio per questi due momenti.
ALCUNI CONSIGLI PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI AL COLLOQUIO
Due sono gli ambiti nei quali puoi lavorare per prepararti al meglio al colloquio:
1. La preparazione nelle diverse materie
2. L'argomento da esporre
1. La preparazione nelle diverse materie
Qui è inutile nasconderci dietro ad un dito. Se non hai mai studiato in vita tua, se fino ad ora ti è sempre andata bene, se risultavi simpatico al prof. e quindi te la sei sempre cavata, ebbene in questo caso potrebbero arrivare delle sorprese. Quattro dei sette membri che compongono la commissione sono esterni (un presidente e tre commissari), ti faranno delle domande specifiche attendendosi delle risposte adeguate, tutto il sistema di rapporti con gli insegnanti che si erano venuti a creare nel corso dell'anno scolastico a questo punto saranno ininfluenti, ciò che ora veramente conta è la tua preparazione nelle diverse materie.
Le situazioni che vivi possono essere diverse, vediamo i casi limite:
a. Mai aperto il libro, eppure sono arrivato agli esami
Se non hai mai aperto il libro, se sei sopravvissuto con le fotocopie degli appunti e dei riassunti fatti dai compagni (perché scrivere è faticoso), se "io so come cavarmela senza studiare, tanto è lo stesso". In questo caso ti aspetta un fine anno di studio "matto e disperatissimo" con risultati che non potranno essere soddisfacenti. Studiare i programmi scolastici annuali di sei-sette materie in un mese, non avendo fatto nulla per tutto l'anno, normalmente genera una grande confusione mentale, oltre che uno stato di stress avanzato. Che fare se ti trovi in queste condizioni ?
STUDIA !!! INIZIA A STUDIARE SUBITO, NON DOMANI O LA PROSSIMA SETTIMANA, INIZIA SUBITO SE VUOI AVERE QUALCHE SPERANZA DI SUCCESSO.
b. Qualche volta ho studiato e qualcosa lo ricordo
Rispetto al caso precedente la situazione qui è migliore. Almeno il libro l'hai aperto qualche volta, qualche occhiata ai contenuti l'hai data, riesci ad orientarti tra gli argomenti delle diverse materie, anche se con qualche difficoltà. Cosa fare se ti trovi in questa situazione ?
Innanzitutto aumenta lo studio, quindi, finché hai del tempo libero, cerca di organizzare i contenuti studiati fino ad ora. Ricorda che è più facile ricordare ciò che passa attraverso la nostra rielaborazione. Molto utile potrebbe essere perciò fare dei riassunti, ordinati, di quanto studiato fino ad ora è un modo per ripassare e, nello stesso tempo, per prepararsi del materiale che ti risulterà utilissimo per ripassare nei giorni prima dell'esame.
c. Ti senti di possedere una sufficiente preparazione su tutte le materie
In questo caso non devi fare nulla di speciale. Magari cerca di potenziare lo studio per migliorare la tua preparazione. In ogni caso ti ripropongo il consiglio dato ai tuoi compagni che si trovano nella posizione b., ossia approfitta di quel po' di tempo che hai ora per prepararti dei riassunti dei contenuti delle diverse materie, ti servono ora per fissare le informazioni raccolte e nelle settimane prima dell'esame ti serviranno per ripassare velocemente.
d. Giudichi buono-ottimo il tuo livello di preparazione, anche in base alle valutazioni che ottieni
Se il tuo livello di preparazione è buono-ottimo, non devi preoccuparti. Se è pur vero che in commissione ti troverai di fronte quattro insegnati che non ti conoscono direttamente, devi anche considerare che gli stessi insegnanti si sono letti la tua scheda di presentazione scritta dal consiglio di classe, sanno benissimo, perciò che sei un ragazzo attento, impegnato e studioso. Anche a te consiglio di prepararti dei riassunti. Ti consiglio anche di lavorare per presentare l'argomento scelto con sicurezza ed efficacia. Da te la commissione si aspetta molto, sarebbe un peccato deluderla con una inadeguata presentazione dell'argomento scelto.
2. L'argomento da esporre
Scegli con cura l'argomento da esporre, ricorda bene che se nelle domande i commissari possono considerare come l'argomento potrebbe essere stato svolto "velocemente" nel corso dell'anno scolastico, possono ipotizzare d'averti chiesto proprio l'argomento che non conosci, ecc. ebbene per l'argomento presentato non hai scusanti. Tu hai scelto quell'argomento, su quello ti sei preparato, su quello hai lavorato. Ingiustificabile risulta, perciò, il non saper concludere il discorso, perdersi per strada, ripetere sempre le stesse cose, dare un peso spropositato ad un tema e trascurare tutto il resto, oppure dopo 15 minuti essere ancora all'introduzione, con il rischio di essere inesorabilmente tagliati. Nella presentazione dell'argomento non hai scusanti, devi assolutamente prepararti bene, è il tuo biglietto da visita, ricorda che cominciare bene, fare una prima buona impressione sulla commissione, è fondamentale!
Come scelgo l'argomento da esporre ?
Cosa non fare:
- L'argomento lo trovo in Internet e così sono a posto.
Meglio non illudersi in questo senso, per una serie di motivi. Primo perché chi ascolta capisce subito se si sta parlando di qualcosa che si conosce veramente, o se si sta semplicemente proponendo un lavoro fatto da altri. Secondo perché verranno fatte delle domande di chiarimento in merito a ciò che si è esposto, se ci si è limitati ad esporre il lavoro fatto da un altro si rischia una pessima figura e una valutazione molto bassa.
- Mantenere "segreto" l'argomento per paura che qualche altro studente della classe "me lo rubi".
Questo comportamento è sbagliato per una serie di motivi: primo perché è importante che tu ne parli con gli insegnanti delle materie coinvolte, per avere dei consigli su come portare avanti il lavoro; secondo perché se non ne parlate tra voi compagni, si rischia che i poveri componenti la commissione debbano sentirsi ripetere per 20 volte, su 25 candidati, la vita e le opere di Pascoli.
- C'è tempo, c'è tempo ... e così arrivare alla settimana prima dell'esame.
Se vuoi fare un lavoro fatto bene devi iniziare per tempo (per esperienza ho visto che il periodo più adatto per mettersi al lavoro è l'inizio del secondo quadrimestre, quando si conoscono le materie, sono stati scelti i docenti interni, vi è una pausa nelle verifiche), considera che potresti cambiare idea nel corso d'opera e quindi ricominciare da zero, non prenderti all'ultimo minuto.
Cosa è bene fare:
- Farsi consigliare dai docenti
- Vedere delle tesine dei precedenti anni, per capire quali argomenti sono stati portati
- Non eccedere con il numero di materie coinvolte nell'esposizione (pur non essendo indicato il numero di materie, ti consiglio di non andare sootto le due materie e non superare le quattro, portare più di quattro materie potrebbe essere controproducente)
- Accompagnare l'esposizione con una mappa concettuale che consenta ai commissari di avere chiaro l'argomento portato, le materie coinvolte, gli argomenti toccati per le diverse materie (come esempio di mappa concettuale ti propongo questo lavoro fatto da una mia studentessa: mappa concettuale relativa all'argomento "L'immagine della donna nel periodo fascista")
- Simula l'esposizione dell'argomento, mettiti davanti ad uno specchio o con un amico, cronometra i tempi (non far durare più di 15' l'intera esposizione), potrai così verificare la tua sicurezza espositiva ed il tempo necessario.
TESINA O NON TESINA ? QUESTO É IL DILEMMA
Veniamo, infine, all'argomento che turba i sonni di molti studenti: la tesina. Innanzitutto è bene che tu sappia che nelle indicazioni ministeriali non si parla di tesina, l'unico riferimento è all'argomento che deve portare lo studente, da nessuna parte è scritto che tale argomento deve essere sviluppato in una tesina. A questo punto la domanda diventa perciò, mi conviene o non mi conviene portare la tesina ? La risposta a questa domanda è piuttosto semplice: dipende da te. Mi spiego meglio. La tesina è un lavoro che accompagna l'esposizione dell'argomento, se hai intenzione di fare un bel lavoro, allora ti consiglio di presentare la tesina, viene a tuo vantaggio l'elaborazione di un testo corretto, graficamente piacevole, ben costruito, ecc.; se invece non hai tempo, non hai voglia è decisamente meglio lasciar perdere. Ti ricordo che la tesina, in quanto lavoro scritto, mostra, inequivocabilmente le tue abilità, ma anche le tue eventuali carenza (penso agli errori ortografici, morfosintattici, alla mancanza di coesione e coerenza, ecc.).
Quindi, in conclusione, se ti senti sicuro, punti a valutazioni alte, senti di poterti impegnare, allora ben venga la tesina (tra l'altro dà sicurezza sapere di essersi già presentati con un proprio lavoro, se ben fatto, alla commissione). Se non ne hai voglia, se le tue capacità di produrre un testo scritto sono assolutamente limitate, allora lascia perdere.
Non lasciarti tentare dall'idea, malsana, di presentare un lavoro fatto da altri, magari una tesina trovata in Internet. Se se ne accorge la commissione, e ti assicuro che è facile accorgersene per dei docenti esperti, per te è finita, puoi rischiare anche l'esame.
COME AIUTARE GLI STUDENTI AD AFFRONTARE L'ESAME
(per insegnanti)
Pagina in costruzione
SULLA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA
(importanti riflessioni prodotte dall'INVALSI)
Nella correzione della prima prova il docente di Italiano è chiamato ad un compito non facile da assolvere. Diverse sono, infatti, le competenze dello studente che è necessario considerare al fine di esprimere una corretta valutazione. Se l'uso di una scheda di valutazione per la correzione della prova ci ha facilitato il compito, è pur vero che spesso proprio le schede di valutazione vengono elaborate secondo criteri che sono diversi da scuola a scuola, da docente a docente. Se possiamo trovarci a disagio nell'utilizzare schede di valutazione elaborate da docenti di un'altra scuola, è anche vero che abbiamo il dovere di chiederci quanto anche le nostre schede di valutazione rispondano ai criteri di oggettività, efficacia ed efficienza.
Il tema della valutazione della prima prova non è una questione da poco, proprio per tale motivo l'INVALSI, con la collaborazione dell'Accademia della Crusca, ha prodotto un testo di riferimento che ritengo di fondamentale importanza per tutti i docenti che insegnano nelle classi quinte. Si tratta del fascicolo La valutazione della prima prova dell'esame di Stato (Frascati 2008).
Nel fascicolo viene proposto di suddividere le competenze da verificare in quattro distinti ambiti:
Competenza testuale
Competenza grammaticale
Competenza lessicale-semantica
Competenza ideativa
Per ogni competenza si propone di assegnare massimo 5 punti, indipendentemente dal tipo di prova affrontata dallo studente. Dal punteggio espresso in ventesimi si passa, grazie ad una tabella di conversione al punteggio in quindicesimi.
La scheda di valutazione proposta è la seguente:
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
Candidato: _________________________________ Classe: _______
Tipologia di prova scelta: □ A; □ B (□ articolo di giornale - □ saggio breve); □ C; □ D
|
INDICATORI (singole competenze) |
DESCRITTORI di ciascuna competenza |
Carenze rilevanti (barrare) |
PUNTI 1-5 |
|
I Competenza testuale |
a) Rispetto delle consegne b) Uso del registro linguistico complessivo adeguato al tipo di testo c) Coerenza e coesione nella struttura del discorso d) Scansione del testo in capoversi e paragrafi, con eventuali titolazioni e) Ordine nell’impaginazione e nell’aspetto grafico (“calligrafia”) |
□ |
... |
|
□ |
|||
|
□ |
|||
|
□ |
|||
|
□ |
|||
|
II Competenza grammaticale |
a) Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità b) Correttezza ortografica c) Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo |
□ |
... |
|
□ |
|||
|
□ |
|||
|
III Competenza lessicale- semantica |
a) Ampiezza del repertorio lessicale b) Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro lessicale c) Padronanza dei linguaggi settoriali |
□ |
... |
|
□ |
|||
|
□ |
|||
|
IV Competenza ideativa |
a) Scelta di argomenti pertinenti b) Organizzazione degli argomenti intorno a un’idea di fondo c) Ricchezza e precisione di informazioni e dati d) Rielaborazione delle informazioni e presenza di commenti e valutazioni personali |
□ |
... |
|
□ |
|||
|
□ |
|||
|
□ |
|||
|
PUNTEGGIO TOTALE (somma dei punteggi delle singole competenze: min. 4, max. 20) |
...
|
||
|
VOTO in quindicesimi |
...
|
||
Mi sento di sostenere questo tipo di approccio alla valutazione della prima prova per una serie di motivi. Primo perché credo vi sia la necessità di
criteri oggettivi di valutazione, indipendenti dal docente che corregge la prova, secondo perché mi sembra che la scheda sia molto ben fatta. Probabilmente qualche collega storcerà il naso all'idea di dover utilizzare una tabella di conversione (che riporto), credo però che esprimere un punteggio in ventesimi e non direttamente il voto in quindicesimi ci consenta di esprimere con maggiore oggettività la valutazione delle diverse competenze.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELLA PRIMA PROVA
Con la scheda proposta si chiede di misurare distintamente le quattro competenze, assegnando a ciascuna un punteggio da 1 a 5:
punti 1(Grave carenza)
punti 2 (Carenza):
punti 3 (Accettabilità)
punti 4 (Sicurezza)
punti 5 (Piena sicurezza)
Dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole competenze si ottiene un punteggio totale da 4 a 20 (in ventesimi) la padronanza linguistica complessiva del candidato.
Si fornisce qui di seguito una tabella di equivalenze per convertire il punteggio in ventesimi in quello in quindicesimi (prescritto dalla legge per la prova d’esame). Il punteggio è raggruppato in cinque fasce corrispondenti ai cinque livelli: 4-7; 8-10; 11-14; 15-17; 18-20.
|
Livelli della padronanza linguistica per competenza linguistica |
Punteggio grezzo in 20mi |
VOTO in 15mi |
|
Grave carenza |
4 |
1-3 |
|
5 |
4 |
|
|
6 |
5 |
|
|
7 |
6 |
|
|
Carenza |
8 |
7 |
|
9 |
||
|
10 |
8 |
|
|
Accettabilità |
11 |
9 |
|
12 |
10 |
|
|
13 |
11 |
|
|
14 |
||
|
Sicurezza |
15 |
12 |
|
16 |
13 |
|
|
17 |
||
|
Piena Sicurezza |
18 |
14 |
|
19 |
||
|
20 |
15 |
Quindi invito tutti i colleghi a leggere con attenzione il fascicolo prodotto dall'INVALSI. Se ritengo che l'utilizzo della scheda proposta per la correzione sia una scelta che deve fare il singolo docente (io ho scelto di utilizzare questa scheda da quest'anno), riflettere con attenzione sui criteri della valutazione mi sembra sia un obbligo che abbiamo tutti.
Contattatimi pure per eventuali chiarimenti.